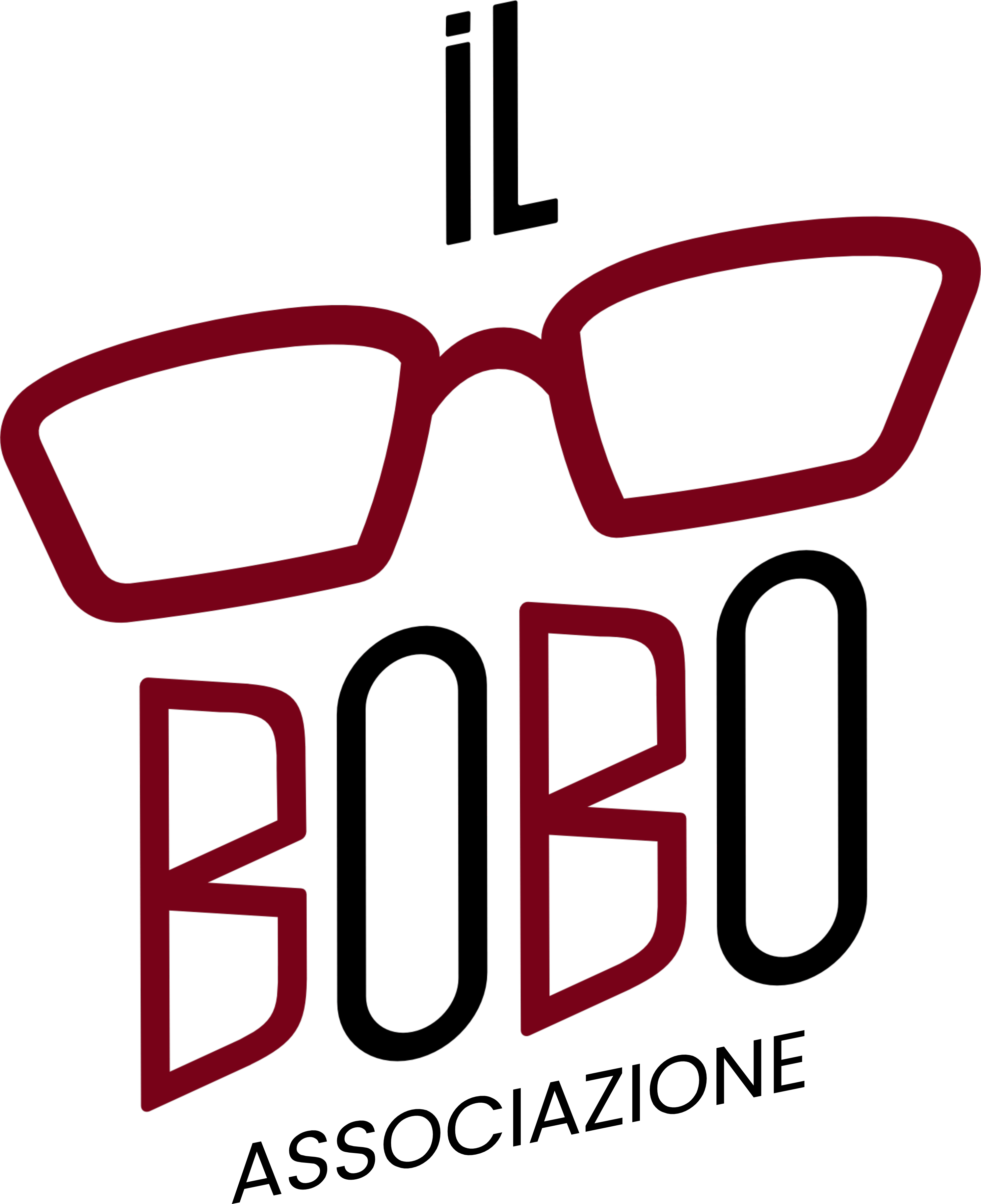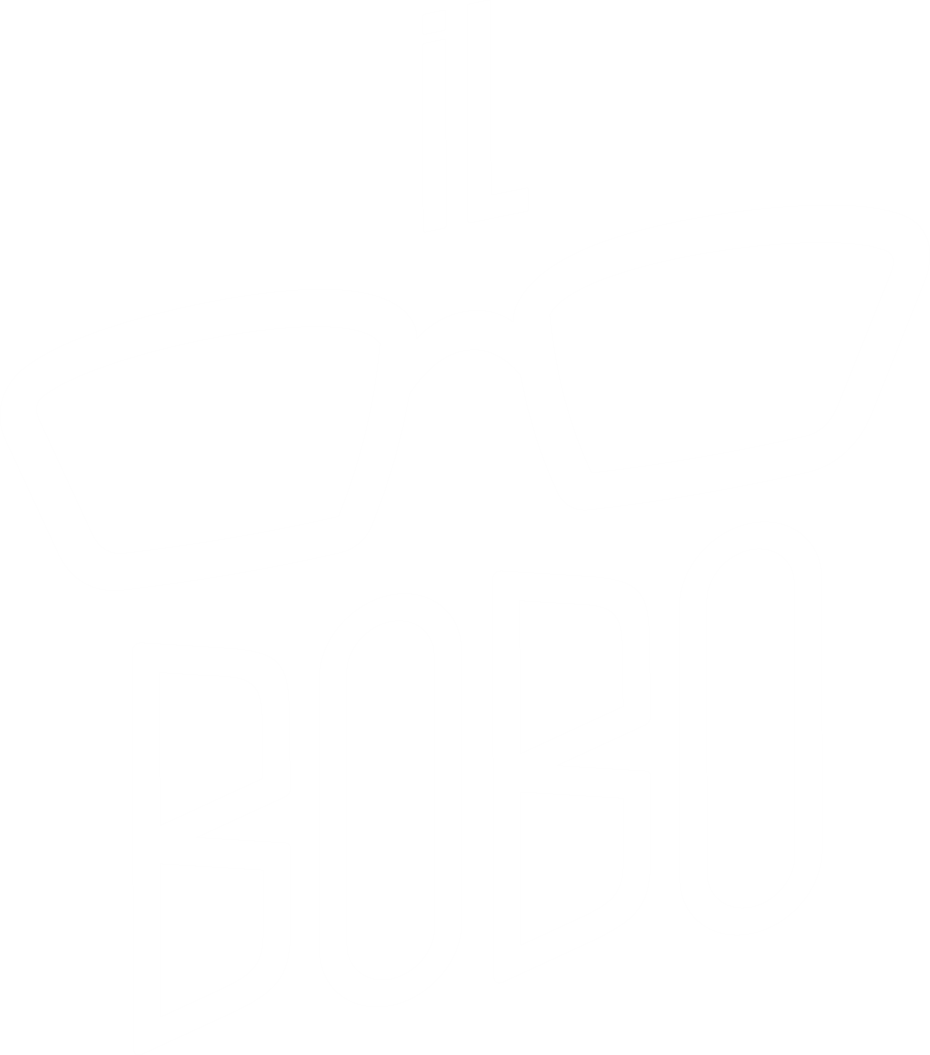Gallarate, 25 Aprile 2025.
Intervento del professor Stefano B. Galli in occasione delle celebrazioni istituzionali dell’ 80° anniversario della Liberazione
Autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche e d’arma, signor sindaco, signori assessori, signori consiglieri, signore e signori, presenti tutti.
Quando una circostanza celebrativa cade in un anniversario «rotondo», qual è quello di quest’anno, l’80mo della Liberazione, l’evento diventa più solenne e carico di significato.
ASSALTO ALLE PREFETTURE. Il 25 aprile di ottant’anni fa, il comando del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale. E diede l’ordine alle forze raccolte nel Corpo Volontari della Libertà di occupare le prefetture delle principali città del Nord (Bologna e Genova, Milano e Torino), prima dell’arrivo delle truppe alleate. Tra il 25 aprile 1945 e il primo gennaio 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana: nel breve volgere di poco più di un paio di anni, si consumò un fondamentale passaggio della storia italiana. Il Paese cambiò forma di Stato e forma di Governo, passò dalla monarchia alla repubblica, dall’autoritarismo dittatoriale alla democrazia. Non v’è alcun dubbio – e lo dico per amore di verità storica e anche per onestà intellettuale – che, senza il decisivo contributo delle forze social-comuniste, l’esito non sarebbe stato lo stesso. Lo riconobbe anche Alcide Degasperi che coinvolse i Comunisti nel suo primo (l’ultimo governo del Regno d’Italia) e nel suo secondo (il primo dell’Italia repubblicana) governo, fino al gennaio-febbraio 1947.
LA COMPETIZIONE SULLA MEMORIA. Un grande esponente della tradizione etico-civile sudtirolese, Claus Gatterer, diceva che non bisogna mai guardare la storia «con un occhio solo». Ogni anno, in Italia si celebra la festa della Liberazione il 25 aprile. Liberazione alla quale hanno contribuito socialisti e comunisti, ma anche liberali, cattolici, azionisti, anarchici e monarchici, ricordiamocelo sempre. E ogni anno – a cominciare dal 1949, quando venne istituzionalizzata formalmente, dopo i decreti del 1946, 1947 e del 1948 – si scatena la competizione della memoria, tra la memoria «rossa» e la memoria «nera». La ricorrenza ha sempre subito forti ideologizzazioni e partitizzazioni, che hanno trascurato e relegato nel dimenticatoio la memoria «grigia», quella di chi scelse consapevolmente di non scegliere e di non schierarsi, cioè dell’antifascista tiepido o del fascista poco convinto. E furono davvero in molti gli italiani inquadrabili nella «terza» Italia, quella riconducibile alla memoria «grigia». Che tuttavia ancora oggi non hanno diritto di cittadinanza politica nella competizione sulla memoria cui assistiamo ogni anno il 25 aprile. Solo una democrazia matura ha il coraggio e la forza di fare i conti sino in fondo – e sottolineo sino in fondo – con il proprio passato.
LA MORTE DELLA PATRIA. Alla fine del conflitto, l’idea di nazione era delegittimata e l’identità nazionale appariva fortemente pregiudicata per effetto della struttura duale del Paese, mai così profonda – dal punto di vista economico e sociale, politico e istituzionale – anche a causa delle diverse esperienze storiche vissute dopo l’8 settembre. La linea Gotica era molto di più di un confine geografico e militare, tra il Regno del Sud di Vittorio Emanuele e di Badoglio, di fatto nelle mani del Governo Militare Alleato, e la Repubblica Sociale, commissariata dalla Germania nazista. Al Nord era diffuso l’orgoglio e la fierezza di essersi liberati da soli. Nei mesi che precedettero il 25 aprile, la classe politica e la classe dirigente s’erano date rapidamente alla fuga rispetto alle proprie oggettive responsabilità, lo Stato si stava dissolvendo e l’esercito era allo sbando. Sui Quaderni del Partito d’Azione, Ugo La Malfa scrisse:
«L’Italia come grande Stato nazionale ereditato dal Risorgimento è stato distrutto. Non è stata distrutta soltanto un’opera di arricchimento spirituale e materiale, che durava dall’unità, non è stata distrutta soltanto una continuità di vita piena di promesse e di avvenire, non è stato distrutto un patrimonio materiale, spirituale, artistico, scientifico faticosamente accumulato, non sono stati distrutti soltanto città e villaggi e industrie, ma sono stati scardinati anche gli elementi primordiali di organizzazione di vita di uno Stato, quelli senza cui non esiste e non può esistere uno Stato, tutte le istituzioni civili, le istituzioni giudiziarie, le istituzioni militari e di polizia, i servizi tecnici, la burocrazia».
Era questa la morte della patria, come l’hanno definita molti storici. Diventava dunque necessario un processo di rigenerazione etica, morale e civile, della popolazione, affinché potesse ritrovare le ragioni più profonde della socialità, cioè dello stare insieme, trasformandosi così in una vera comunità nazionale di cittadini liberi, essenza del nuovo Stato democratico.
Il compianto storico inglese Christopher Duggan s’è correttamente posto questa domanda:
«Per oltre vent’anni il fascismo si era sforzato di appropriarsi dello Stato e della nazione, adottando la monarchia, lo Statuto, il sistema amministrativo e (dal 1929) la Chiesa […]. Adesso, tra il naufragio del regime da un lato e dall’altro la rabbia viscerale (esemplificata dalle macabre scene di piazzale Loreto) esplosa contro gli uomini ritenuti i massimi responsabili della débâcle del paese, dove poteva rivolgersi l’Italia in cerca dei materiali con cui costruire il suo futuro?».
BOBBIO E CATTANEO. Nel 1945, Norberto Bobbio diede alle stampe l’antologia degli scritti di Carlo Cattaneo Stati Uniti d’Italia. Bobbio, nella sua Introduzione, spiegava in modo convincente il senso della sua riscoperta cattaneana.
«Se uomini e istituzioni vi sono – scriveva Bobbio, poi divenuto uno dei padri nobili della sinistra – che a questa recente e spietata distruzione resistono per una interiore vitalità del loro pensiero o della loro struttura, di essi non possiamo non tener conto per l’opera ricostruttiva. A essi dobbiamo gettare l’arco di quel ponte che ci consente di riunirci al passato, per ritrovare la forza e il conforto di una tradizione, senza la quale ogni avanzamento è un passo nel buio, ogni dottrina corre il pericolo di risolversi in un astratto vagheggiamento».
Per quanti consideravano l’affermazione dell’autoritarismo fascista come l’antitesi della libertà individuale, come oggettivamente fu, il pensiero del grande Carlo Cattaneo, un radicale, democratico e repubblicano, liberale e antimonarchico, non poteva che essere un ineludibile punto di riferimento, per l’enfasi che pose sulle tradizioni civiche territoriali, sulla necessaria scomposizione federale della sovranità, nella consapevolezza che solo il potere può controllare il potere, sul pluralismo delle istituzioni politiche e amministrative, sulla prospettiva della federazione europea: Stati Uniti d’Italia dentro gli Stati Uniti d’Europa.
L’EUROPA E LA SUA COSTITUZIONE. Stati Uniti d’Europa, appunto. A proposito del Manifesto di Ventotene sul quale di recente si sono innescate infuocate polemiche, vorrei fare un paio di precisazioni.
La prima. Nelle polemiche non è stato ricordato, ma Altiero Spinelli auspicava – nella miglior tradizione del costituzionalismo europeo – la convocazione di un’Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, per dare una veste autenticamente democratica al processo di costruzione di una federazione europea (non una confederazione di Stati!). Ma così non fu. L’Europa fu il frutto di un’azione dirigista che ha determinato il primato della burocrazia e della tecnocrazia, dell’economia e della finanza, con la quale facciamo i conti ancora oggi. Ricordiamoci che tra poche settimane, il 29 maggio cadrà il ventesimo anniversario dei referendum francese e olandese che, nel 2005, hanno clamorosamente bocciato quella che impropriamente viene chiamata Costituzione europea. Non è affatto una Costituzione, ma un trattato di natura economico-commerciale, esuberante nei suoi 448 articoli (non si è mai vista una «Costituzione» di quasi 450 articoli! Di solito si tratta di testi asciutti e agili, composti da pochi articoli, finalizzati a definire le regole e i valori di fondo del vivere associato di una comunità). Quella europea non è affatto una Costituzione, ma un trattato di natura economico-commerciale, elaborato in deficit di potere costituente, visto che l’hanno scritto i membri della Conferenza Intergovernativa e non un’Assemblea Costituente, titolare legittima del potere Costituente, là dove risiede la sovranità popolare, come ci ha spiegato il giacobino Joseph-Emmanuel Sieyès, uno dei più grandi tecnici delle Costituzioni moderne, secondo Gianfranco Miglio.
LA CARTA DI CHIVASSO. La seconda precisazione: Ventotene contro Chivasso. Il 19 dicembre 1943, tre mesi dopo la resa senza condizioni dell’8 settembre, a Chivasso, s’incontrarono clandestinamente i delegati del movimento resistenziale valdostano e i delegati valdesi. Stesero la Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, nota anche come Carta di Chivasso, in cui l’autonomia e il federalismo, quello vero, quello di Cattaneo, s’imposero – in funzione antifascista e antitotalitaria – secondo una dimensione ideologica e politica di respiro europeo. Da Chivasso, i valdostani e i valdesi, guardavano alla federazione europea sul modello svizzero, guardavano all’Europa dei popoli e dei territori, non all’Europa degli Stati. E pochi mesi dopo arrivò il pamphlet di Émile Chanoux, giovane leader – tra i protagonisti dell’incontro di Chivasso – dell’area federalista più radicale del movimento resistenziale valdostano, Federalismo e Autonomie, che uscì postumo nei Quaderni del Partito d’Azione nel 1944. «Fu la monarchia – scriveva il notaio valdostano, repubblicano e federalista – a portare, con la sua adesione supina al fascismo, l’accentramento statale italiano alle sue estreme conseguenze: la dittatura». E ammoniva che «una repubblica accentrata non sarebbe stata affatto migliore di una monarchia». Frase sulla quale ancora oggi sarebbe necessario riflettere a fondo. Chanoux – capo del CLN valdostano – venne poi barbaramente pestato e ucciso dai fascisti nel carcere di via Frutaz, ad Aosta, il 18 maggio 1944, all’età di 38 anni.
IL CISALPINO. Nella vostra biblioteca civica Luigi Majno, qui a Gallarate, è rimasta una delle ultime collezioni complete del «Cisalpino. Settimanale federalista nazionale». È in buono stato; è quella che ho consultato io nei miei studi, visto che sto per pubblicarne un’antologia di articoli del settimanale. E mi rivolgo al vostro Sindaco: tenetela da conto!
Il 27 aprile 1945, a Como, uscì il primo numero del «Cisalpino». Ospite in Prefettura, Mussolini – aggregato a un convoglio militare tedesco – tentava di fuggire (la colonna venne fermata da un posto di blocco della 52ma Brigata Garibaldi «Luigi Clerici» nei pressi dell’abitato di Musso, in cima alla sponda occidentale del Lario). Dopo l’occupazione della tipografia del quotidiano fascista La Provincia di Como, un gruppo di giovani Comaschi e Varesotti, che gravitavano attorno alla Democrazia Cristiana clandestina, fece uscire il primo numero del «Cisalpino».
Questi giovani cisalpini erano guidati dal professor Tommaso Zerbi di Cermenate e dal giovane Gianfranco Miglio di Como. E al giornale collaboravano vivissime intelligenze: un grande giurista, Antonio Amorth, un grande storico dell’economia e dell’agricoltura lombarda, Aldo De Maddalena di Coquio Trevisago, un grande storico dell’età contemporanea, Gianfranco Bianchi di Como, solo per fare qualche nome.
Il 27 aprile 1945, il primo numero del «settimanale federalista nazionale» aprì a caratteri cubitali: L’insurrezione trionfa in Valpadana. Di spalla, l’editoriale, firmato da Zerbi, dal titolo: Cantoni, non Regioni. Di fronte all’ormai imminente conclusione del conflitto, alla rifondazione del Paese e alla prospettiva della svolta repubblicana, l’idea era quella di proporre – in funzione antifascista e antimonarchica – un nuovo ordine politico e istituzionale di ispirazione federale su base cantonale. Il modello era quello svizzero e i cantoni pensati dai cisalpini erano tre, a cominciare dal Cantone Cisalpino del Nord. Per i Cisalpini il federalismo era assai più di una migliore organizzazione amministrativa, efficiente e funzionale, utile a scongiurare pericolose derive autoritarie: «oggi più che mai il sopravvivere delle libertà democratiche è in Italia legato al fatto di una coraggiosa e radicale innovazione della struttura dello Stato, uno Stato nuovo e radicalmente federale», scrivevano.
Il federalismo dei Cisalpini era sinonimo di antifascismo, era una cultura politica, un costume ideale, una dimensione interiore, un’autentica vocazione, una categoria dello spirito. 27 aprile 1945, ottant’anni fa. La prospettiva federalista – Chivasso, Bobbio e Cattaneo, Il Cisalpino, solo per fare alcuni esempi – era ampiamente diffusa e veniva considerata l’unica prospettiva antitotalitaria e antifascista.
Ripeto: una democrazia, se è davvero matura, deve avere la forza e il coraggio di fare i conti con la complessità della propria storia, con la complessità del proprio passato, per superare steccati e barriere ideologiche, andare oltre le ideologizzazioni e le partitizzazioni. Solo allora si potrà parlare di una memoria condivisa, nel segno della riconciliazione nazionale, senza inutili e sterili competizioni sulla memoria. Che lasciano il tempo che trovano. Grazie!