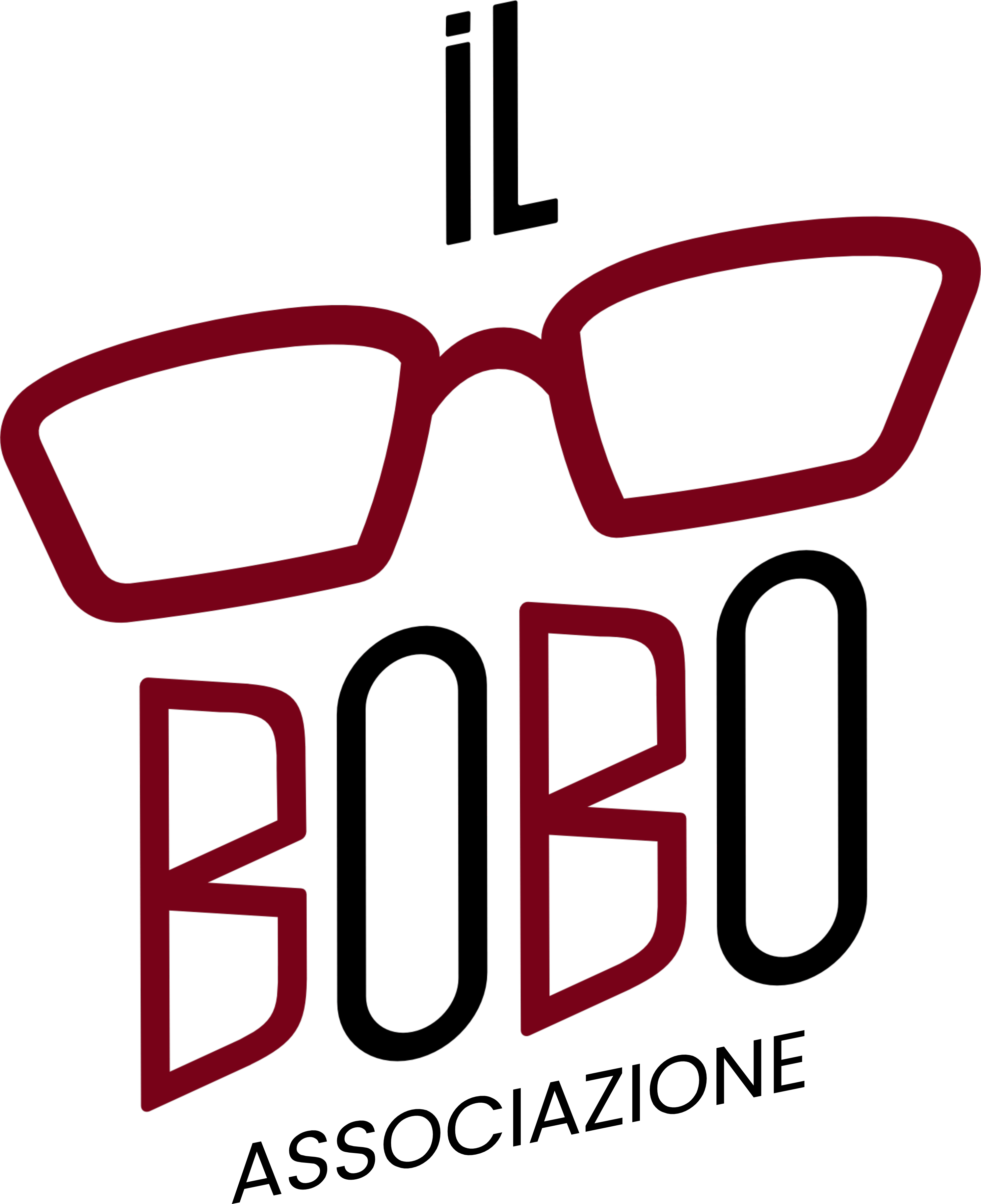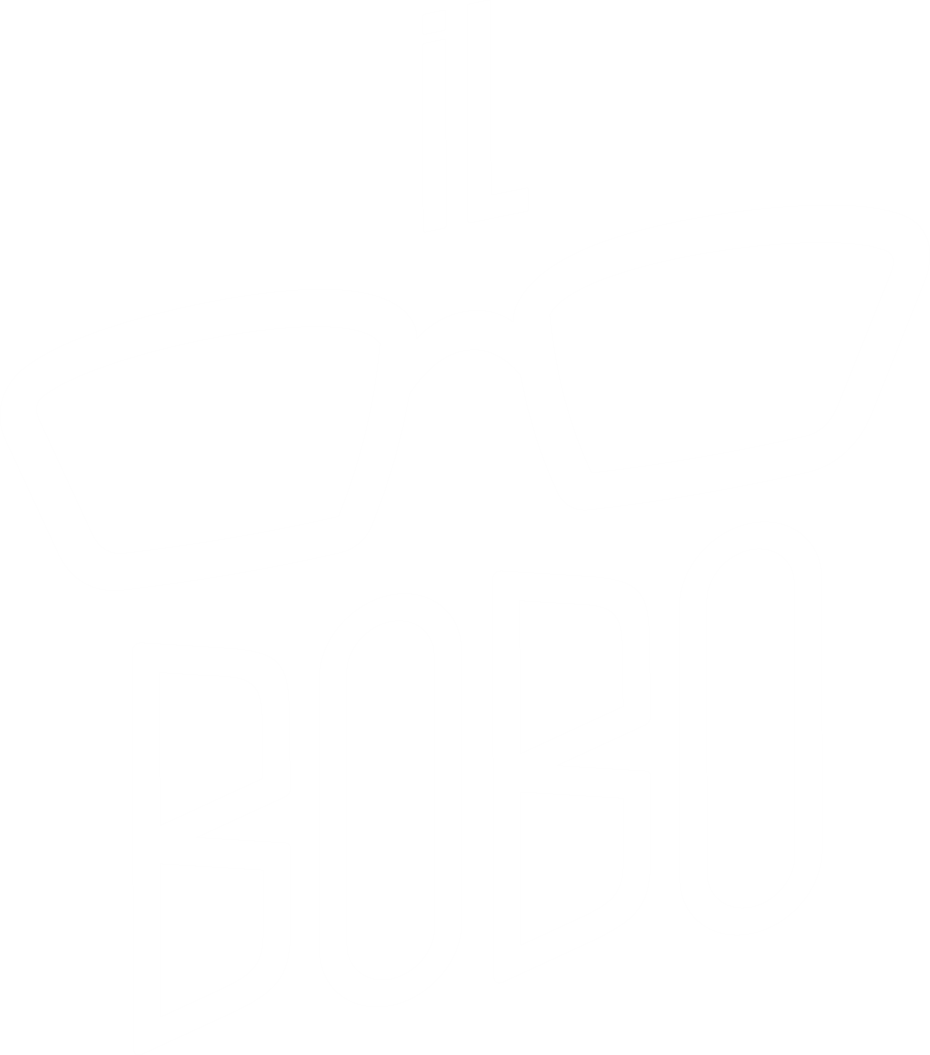L’intuizione di Carlo Cattaneo
Pensare al ruolo della città nella storia del pensiero politico significa da un lato identificare un «motore» ideale, oggetto di riflessioni e di speculazioni teoriche in qualche modo astratte, dall’altro confrontarsi con l’identità irripetibile delle comunità volontarie territoriali, nell’ambito delle quali ogni singola città si è imposta come perno di relazioni culturali, laboratorio privilegiato che ha sollecitato pensieri e idee politiche nei singoli scrittori politici. In questo senso il fulcro della riflessione di Carlo Cattaneo (1801-1869) è strettamente legato a un contesto preciso, quello milanese, di cui è stato indiscusso protagonista, almeno sino alla primavera del 1848.

Non v’è alcun dubbio che il clima effervescente e dinamico della città di Milano, pensiamo all’avventura editoriale del «Politecnico», al Congresso degli Scienziati del settembre 1844 e alle Notizie naturali e civili su la Lombardia, vero e proprio manifesto di «lombardismo», alle Cinque giornate di quattro anni dopo e al testo Dell’Insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra, esercitò una notevolissima influenza sulla riflessione di Carlo Cattaneo. L’idea di città costituisce infatti un interessante filo rosso che tiene insieme e percorre la riflessione cattaneana dall’inizio alla fine, dai primi esercizi di pensiero e di scrittura, alla sequenza di articoli pubblicati sul «Crepuscolo» di Carlo Tenca sul finire degli anni Cinquanta e originati dall’idea di recensire l’appena pubblicata Histoire des révolutions d’Italie dell’amico Giuseppe Ferrari.
Lo scrittore politico milanese, protagonista delle Cinque giornate, pensa alla città come all’elemento essenziale della storia d’Italia. Un tema che gli consente di approfondire il rapporto fra l’uomo e la vita associata, tra l’ambiente naturale e le comunità politiche che si sono organizzate sul territorio. Anche nell’Insurrezione di Milano, il volume che Cattaneo esule prima in Francia e poi in Svizzera, a Castagnola nei pressi di Lugano, dedica alle vicende del Quarantotto, parla delle città e dell’ordine cittadino come «anima della nazione», dove l’idea di «ordine» si definisce nel rapporto equilibrato fra la città e il territorio provinciale, cioè il contado. Senza questo ordine «è facile cadere in errore di prospettiva e si è costretti a rinunciare a raggiungere risultati che soltanto la concordia interna è in grado di promuovere».
Si tratta di uno schema interpretativo che, saldamente radicato e circostanziato in un luogo preciso, riesce a estendere la sua validità ben oltre l’«orto di casa». Secondo Cattaneo la città è «l’unico principio per cui possono i trenta secoli delle istorie italiane ridursi a esposizione evidente e continua. Senza questo filo ideale la memoria si smarrisce nel labirinto delle conquiste, delle fazioni, delle guerre civili e nell’assidua composizione e scomposizione degli Stati; la ragione non può veder lume in una rapida alternativa di potenza e di debolezza, di virtù e corruttela, di senno e imbecillità, d’eleganza e barbarie, d’opulenza e desolazione; e l’animo ricade contristato e oppresso dal sentimento di una tetra fatalità».
Per Cattaneo non sono i princìpi di autorità intangibili e astratti del potere imperiale e del potere papale a illuminare e a dare coerente continuità ai processi storici, ma la costante presenza di comunità politiche di cittadini, fondate sulle libertà civili individuali e sulla partecipazione; il principio unificante è la città strettamente connessa alla campagna circostante, che è insieme mercato e polis che si autogoverna, dove il dialetto si affianca alla lingua comune, dove si coltivano la scienza e le attività «borghesi», contribuendo in tal modo alla nascita e allo sviluppo della civiltà moderna. Con ciò afferma, in termini moderni e oggi più attuali che mai, il primato della società come motore della storia e dello sviluppo. La città italiana ha una sua peculiarità e una sua specificità: «Fin dai primordi la città è un’altra cosa in Italia da ciò ch’ella è nell’oriente o nel settentrione» europeo. Le città italiane sono caratterizzate dall’ordine, dal diritto comune e dalla dignità municipale, dall’intima unione col territorio e dalla tenace convivenza dei signori che non vollero mai relegarsi nella campagna che li nutriva, né sommergersi nella capitale che li opprimeva.
Il libero comune è fondato sugli Statuti di autonomia come quello milanese del 1216 ed espressione di una società fondata sull’indipendenza economica, le libertà individuali e la partecipazione al governo municipale dei nascenti ceti borghesi che si collegano agli abitanti del contado. Libertà economica, affermazione della borghesia e sviluppo della società sono gli elementi essenziali dell’idea di città di Cattaneo. La città è anche il luogo dove si afferma il metodo scientifico sperimentale, è il fondamento del progresso civile, dove la scienza si incontra con l’arte e l’artigianato e i diversi ceti sociali collaborano in base a un condiviso senso del diritto e della dignità civile.
L’autonomia municipale è storicamente interpretata dalle città lombarde a cominciare da Milano. Un primato che, pur in un contesto apparentemente mutato, in realtà chiama ancora in causa gli stessi rapporti sociali, economici e politici, che segnano la frattura delle libertà civili contro la mentalità coloniale, della cultura del rischio d’impresa e della dedizione al lavoro, dello spirito di abnegazione, contro la fiscalità parassitaria, dei rapporti orizzontali tra territori contro l’oppressione «verticale», gerarchica e burocratica, delle istituzioni astratte come lo Stato centrale e la Commissione Europea. Una lezione da tenere ben presente, per ricordare come l’azione politica e culturale scaturisca da sorgenti che trovano origine e compimento nel nome, nella storia e nel destino della nostra grande Lombardia.